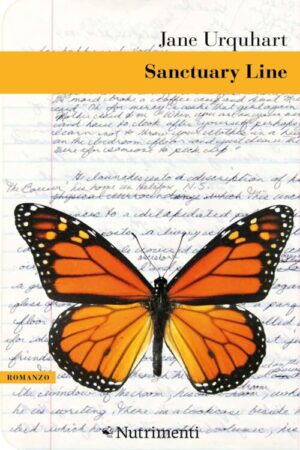Il libro attacca con un pianissimo, un’introduzione di accordi apparentemente improvvisati, di note irrelate, salti temporali, flash-back, ricordi improvvisi, accenni casuali, sporadiche reticenze, inferenze incongrue quali suoni indistinti di chi accordi lo strumento prima che si dispieghi la tragica sinfonia della dolorosa rimembranza e tramite il racconto si disveli un mondo sommerso, perduto per sempre, che risorge nella scrittura per permanere congelato nel romanzo, attraverso la magia della parola.
«A volte sento che il passato mi mangerà viva, mi divorerà allo stesso modo in cui la siepe di cedri sta invadendo e divorando le staccionate dei pionieri su cui da bambini ci sedevamo per guardare i messicani lavorare. Temo che diventerò come una di quelle donne che talvolta s’incontrano a fare la spesa al supermercato in città, trasandate, vagamente pazze, assenti, che parlano sotto voce con se stesse mentre spingono disorientate il carrello verso il settore delle verdure»
Un mondo fatto di grandi aziende agricole e di coltivatori diretti che si susseguono di generazione in generazione, di braccianti messicani, di frutteti nei quali volano nugoli di farfalle monarca, di guardiani di fari, di fienili bruciati o dispersi dall’uragano (insieme a una giumenta ritrovata dopo due giorni a cinque campi di distanza, intenta a pascolare tranquillamente) di due famiglie speculari che vivono sulle sponde opposte del lago Erie, una in Canada e l’altra negli Stati Uniti, che uniranno i loro destini grazie a un matrimonio.
Un mondo in cui spicca l’aristocratica sprezzatura della zia Sadie e la volontaria dimenticanza di mamma Beth; un mondo fatto di giochi tra cugini nelle estati felici dalla luce abbagliante, con la presenza di Teo, il piccolo messicano accolto nel loro cerchio magico; un mondo segnato più recentemente dalla morte di Mandy, ma più nel profondo dalla scomparsa di zio Stanley, il pilastro della famiglia, personaggio dalla figura ambigua, il vero enigma di questo romanzo.
«Adesso trascorro il tempo a fare avanti e indietro fra il campo e il laboratorio, fra i vivi e i morti. Tutto è a rischio, non solo la Danaus plexippus arancione e nera della famiglia dei Lepidotteri, ma ogni cosa. I vecchi fienili – quelli non bruciati o non abbattuti – cedono e cadono a pezzi. Le piccole chiese bianche sono quasi vuote la domenica, se non sono già state vendute e trasformate in caffè o negozi d’antiquariato. Tutti i miei avi e le loro case riposano negli album di famiglia, chiusi e non visti da nessuno. E né la mia adorata cugina né il mio enigmatico e tormentato zio faranno mai ritorno»
Sanctuary Line ha l’andamento lento di un grande classico. Jane Urquhart è una narratrice di razza che con calma tesse la doppia, la tripla trama del suo fastoso arazzo di parole. È un’autrice che ricorda Alice Munro e Margaret Atwood: lascia sassolini lungo il racconto, delle allusioni, degli indizi, che alla fine del percorso, della lettura, tornando indietro si trasformeranno in gemme preziose per cogliere a pieno il senso della vicenda narrata che ha un andamento circolare, una visione in “chiaroscuro” e l’insegnamento che offrono solo i grandi romanzi: ovvero che nulla si risolve, ma ognuno è portatore della propria visione e della propria verità.
La voce narrante è un membro della famiglia Butler, l’entomologa Liz, che torna presso Sanctuary Line per seguire alcune ricerche sulle farfalle monarca. Dal suo presente riaffiora lentamente tutta la storia della sua famiglia e le madelaine sono proprio i lepidotteri. Farfalle che divengono metafora dei vizi e delle virtù degli uomini, che divengono il mezzo attraverso il quale decifrare l’enigmatico comportamento della razza umana:
«Mio zio era come una di quelle poche monarca vulnerabili, o forse più esattamente come le loro imitatrici, le viceré. La maggior parte di noi ne vedeva solo il colore e la grazia, e credevamo, di conseguenza, che fosse invincibile. I suoi nemici, se ne aveva, erano colpiti dalla sua persona e rispettavano il suo territorio colorato e le sue doti. Solo qualcuno molto vicino a lui sarebbe stato in grado di percepirne la vulnerabilità, l’impotenza di fronte a un attacco. Solo chi gli avesse dormito accanto per migliaia di notti avrebbe potuto sentire l’odore delle sue debolezze. Forse – parte di me vuole ancora crederlo – non c’era nessun veleno nascosto in lui. Forse non c’era nulla di pericoloso nel suo fascino»
Un libro davvero incommensurabile, un racconto che affascina e che avvince con la sola forza, teterrima, della parola e che procede snocciolando piccoli fatti e divagando per narrazioni secondarie, così da tenerci inizialmente nel dubbio, lasciandoci sbirciare da dietro l’intricato rovescio apparentemente e volutamente irrisolto e confuso del tappeto narrativo, mentre alla fine, guardando il disegno da maestro finalmente completo, appare straordinariamente opulento, maestoso, degna conclusione di un thriller sentimentale in cui tutti i tasselli sono andati alla fine al loro posto.
Jane Urquhart
Sanctuary Line
Traduzione di Nicola Manuppelli
Nutrimenti, 2016